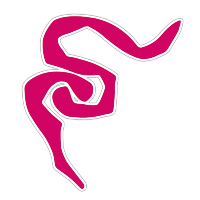Il confronto, a distanza di anni, con gli allievi che hanno frequentato la nostra scuola, costituisce un momento di profonda riflessione per tutta la comunità educante. Quando i ragazzi giungono alla prima fase dell’età adulta, intorno ai 24/25 anni, cioè quando la loro vita interiore spirituale assume per la prima volta una forma personale, diventa per loro possibile cogliere con maggiore chiarezza cosa ha significato per la loro formazione l’esperienza scolastica precedente. Ad una nostra richiesta di testimonianza a diversi ragazzi di una stessa classe, tre di loro hanno prontamente accolto il nostro invito e volentieri pubblichiamo le loro riflessioni.
Maestro Luca
“Ci sono molti momenti nella vita di una persona in cui è saggio fermarsi per un momento e guardarsi indietro, fare, per così dire, un bilancio. Io stessa ne ho fatto uno recentemente, partendo dai momenti che custodisco più gelosamente: quelli passati nella scuola steineriana di Oriago.
Ho ormai perso il conto di quante volte ho dovuto spiegare cos’era e cosa ha rappresentato per me; la verità è che un’esperienza del genere è difficilmente qualificabile in parole, ma ci ho sempre provato, credendo fermamente che potesse ispirare le persone come ha ispirato me.
Trovandomi in queste situazioni, e non potendo semplicemente snocciolare undici anni della mia vita, ho deciso di raccontare esperienze che hanno lasciato un grandissimo segno nella mia anima. Uno dei ricordi che ancora oggi mi fanno sorridere e mi scaldando il cuore è, senza dubbio, il lavoro manuale; conservo ancora gelosamente ogni cosa fatta durante la scuola. In una piccola vetrina c’è un sacchetto di panno pieno di piccole sfere di cera d’api, con le quali ho imparato a contare, sopra alcune mensole ci sono un candelabro e un cofanetto -entrambi in legno- che ho io stessa intagliato, e ancora, una ciotola di rame che inizialmente era un semplice disco. Ogni volta che poso il mio sguardo su uno di questi oggetti posso chiaramente ricordare quando l’ho fatto, a cosa mi è servito farlo e l’orgoglio che ho provato quando lo portavo a casa per mostrarlo alla mia famiglia. Sapevo che non era la ciotola più rotonda o bilanciata, che avrei potuto dare una forma diversa al mio scrigno o che magari il candelabro doveva avere una forma più tondeggiante, ma riuscivo comunque a vedere il mio lavoro, la mia crescita e la mia fatica in ognuno di questi oggetti. E sono sicura che questo sentimento non mi abbandonerà mai.
Ricordate quando vi ho detto che custodisco tutto gelosamente? Non stavo scherzando, perché in una scatola, vicino a dei libri, potete trovare le mie pagelle. Il tipo di pagelle che quasi nessuno ha, quelle che non segnano i voti o le note di merito, ma i tuoi progressi, la tua crescita interiore e lo sviluppo dell’Io.
Quando il mio percorso nella scuola steineriana è finito, le ho spesso e volentieri rilette, riconoscendomi nelle parole attentamente scritte e nei disegni così reali che il mio Maestro aveva fatto per me ogni anno.
Il cammino della nostra vita è lungo, può spesso cambiare direzione e magari farci trovare in luoghi che non conosciamo, ma in noi ci sarà sempre una parte dei bambini che siamo stati; per questo, ogni volta che leggo le parole scritte nelle mie pagelle ritrovo i ricordi di una bambina molto vivace, birichina e sempre pronta a giocare; e nonostante siano passati molti anni, so che riuscirò sempre a trovarla lì, pronta a ricordarmi da dove è partito il mio viaggio e dove è diretto.
Un’ultima cosa: quando frequentavo l’ultimo anno di superiori, la mia professoressa di pedagogia mi chiese di preparare una presentazione sul metodo steineriano, sulla mia esperienza come alunna e su cosa pensavo mi avesse lasciato.
Ho così iniziato a scrivere pagine su pagine riguardanti il metodo usato nella scuola, la vita di Steiner, i libri che aveva scritto, le conferenze e le collaborazioni; arrivai così ad avere un malloppo di ben cinquanta pagine, molta confusione in testa e poca fiducia in come sarei riuscita a spiegare ai miei ventidue compagni cos’era davvero la scuola steineriana.
Alla fine decisi che, il miglior modo per rappresentare la mia esperienza, per farla comprendere davvero, era chiedere consiglio a colui che l’aveva insegnata a me: il mio Maestro.
Il giorno in cui ritornai a scuola, dopo qualche tempo lo ammetto, rimasi stupita da quanti sentimenti riemersero alla sola visione dell’altalena dove tutti volevamo salire, le collinette dove ci rincorrevamo scalzi, gli alberi che cantavano una calma melodia con le loro foglie e il punto dove ero solita mettermi quando toccava a me fare la conta per nascondino.
Vorrei potervi spiegare con parole migliori il sentimento di calma e tranquillità che mi pervase, l’improvvisa realizzazione di cosa non avevo inserito in quelle cinquanta pagine, quanto mi ero sbagliata quando avevo pensato che delle semplici nozioni potessero far comprendere un sentimento di appartenenza così profondo e indissolubile; perché anche se quell’altalena aveva fatto dondolare altri cento bambini e quelle collinette erano state testimoni di nuovi giochi, erano e sono ancora un po’ mie.
Ma non vorrei prendermi tutto il merito: una lunga chiacchierata con il mio Maestro, vederlo con altri alunni, ricordarmi quando io stessa ero seduta ad uno di quei banchi mi ha fatto nuovamente vedere la meta.
Appena arrivata a casa, ricominciai tutto da zero; selezionando attentamente ciò che volevo comunicare e quello che davvero era importante; il giorno dopo mi procurai una capiente scatola in cui misi alcune delle cose che avevo fatto nelle lezioni di Lavoro Manuale, i quaderni scritti interamente da me (scegliendone uno per ogni anno), le pagelle e tutto ciò che mi sembrava comunicasse il giusto messaggio.
Ora vi starete chiedendo com’è andata a finire, vero?
Molto molto bene, più di quanto tutti avessero previsto, più di quanto si aspettassero; la chiave non era sommergerli di fatti e nozioni, ma farli sentire come mi sono sentita io per undici anni e anche chi non ne aveva mai sentito parlare, chi era scettico e chi era abituato a fare qualche battutina, tutti loro hanno condiviso, almeno per un po’, la fortuna e il privilegio che io ho avuto.
E per tutti questi ricordi, queste emozioni e questo percorso non smetterò mai di ringraziare mia madre che me ne ha dato la possibilità e la scuola steineriana di Oriago, ma soprattutto il mio Maestro, che porto sempre nel mio cuore.”
Valentina
Sono passati circa dieci anni dal mio ultimo giorno di scuola steineriana. Da quella volta sono tornato ad Oriago una,o forse due volte. Nel frattempo ho viaggiato, studiato e lavorato tra il Regno Unito, l’Italia, il Belgio e gli Stati Uniti. Mi sono trovato in numerose occasioni a dover raccontare la mia esperienza nella scuola Waldorf ed ho sempre fatto fatica. Non so mai da dove partire. La figura di Rudolf Steiner? il maestro unico? la zappa? prima il canto e dopo la matematica? le epoche? gli esperimenti? le gite? il lavoro manuale? E poi che c’entrano le sigarette e gli hotel?
Chi conosce la scuola steineriana di solito ha già un’opinione ben formata. Gli Italiani pensano sia una scuola per ricchi o privilegiati, quella dove Berlusconi ha mandato i suoi figli. Gli Inglesi hanno un’idea completamente diversa, molto romantica. Per loro è la scuola degli hippie. Con la pittura, l’arte, il gioco…tutte cose sofisticate, dell’Europa continentale, come quelle che si possono leggere nelle poesie di Coleridge, Keats o Byron scritte al ritorno dai loro Grand Tours. In Germania ed Austria la conoscono tutti e pensano che la Waldorf Schule sia solo per ‘ragazzi con problemi’. I Tedeschi in particolare chiedono sempre se è vero che sappiamo ‘danzare il nostro nome’. Il mio quesito preferito, poiché richiede una spiegazione dell’euritmia. Sono passati dieci anni e non ci ho ancora capito niente.
Viaggiando quest’estate in Slovenia in compagnia di amici ho incontrato un ragazzo svedese in un bar. Si chiamava Måns e mi ha detto che aveva appena finito le superiori in una scuola steineriana. Era vestito con abiti di seconda mano, a piedi nudi, puzzava un po’ e diceva che stava girando l’Europa al seguito di un circo. Un’amica mi ha subito fatto notare che sono stato fortunato a non essere diventato matto dopo otto anni di Steiner-reclusione. Da quel giorno mi sono chiesto, con riflessioni più profonde, che significato avesse avuto per me la scuola steineriana. E soprattutto fino a che punto fosse stata determinante per le mie scelte future.
Innanzitutto ho pensato che il circo fosse una cosa molto interessante, mentre la mia amica aveva già qualificato il mestiere come sciagurato. Poi mi sono chiesto come mai non avessi intrapreso il circo invece che studiare ‘le cose internazionali’. Ma ho subito capito che la scuola c’entrava solo marginalmente con tutto ciò. In altre parole, era abbastanza chiaro da tempo che io non sarei diventato circense, mentre Måns il vichingo probabilmente saltava come un grillo già dalla nascita. Credo insomma che il ragazzo svedese ed io abbiamo fatto la nostra scelta indipendentemente e che la scuola ci abbia aiutato a farla, ma non ha cambiato i nostri talenti. Semmai li ha protetti, plasmati e fatti sbocciare. Un po’ come la terra coi fiori.
Måns ed io abbiamo sicuramente qualcosa in comune. Credo che la scuola ci abbia trasmesso la curiosità di girare il mondo. Ci abbia insegnato la libertà. Ci abbia dato la consapevolezza che ogni intraprendenza ha il suo tempo e che le scelte nella vita vanno fatte con la testa ma anche col cuore, senza paure, che uno voglia diventar circense o banchiere.
Quando ero piccolo, non sapevo nulla di tutto ciò; pensavo di vivere un po’ fuori dal mondo ad Oriago, col grembiule ed il flauto di legno; mentre i miei amici, che non frequentavano la mia scuola, facevano di quelle partite di FIFA 98 stratosferiche. Io ero invidioso ma mi era stato detto che avrei cambiato idea. E così è andata. Ho cambiato idea e oggi sono grato ai miei genitori per avermi fatto svegliare la mattina alle sei per andare ad Oriago, per otto anni di seguito. E anche per avermi proibito (per un po’) la televisione ed i videogames.
Ho 24 anni, mi laureo a fine maggio e risposte non ne ho. Gli otto anni passati da pendolare tra Treviso ed Oriago mi sono rimasti dentro, in tutto e per tutto. Non dimenticherò mai i miei amici ed il mio maestro. Quando mi chiedono della scuola mi verrebbe da dire: “Guarda me, mi vedi? Ero un po’ così anche prima. Per fortuna la scuola non ha fatto troppi danni”.
Francesco
Se dovessi riassumere in una sola frase l’insieme dei valori che ho imparato attraverso il mio lungo percorso nella scuola Waldorf, non potrei che citare il primo stasimo dell’Antigone di Sofocle: “Molti i prodigi ma nulla è più prodigioso dell’uomo”.
Sono passati ormai otto anni da quando ho concluso la mia esperienza presso la nostra scuola e oggi, arricchito da ulteriori esperienze come il conservatorio e gli studi classici, riesco a vedere sotto una nuova luce le singole fasi di tale percorso.
Mi appare di primaria importanza la centralità del valore dell’individuo nella sua straordinaria irripetibilità, incentivato e pazientemente accompagnato fin dai primi anni di asilo: attraverso un’educazione che ora definirei “maieutica”, supportata in particolar modo da varie forme d’arte (sia negli aspetti pratici e manuali che in quelli teorici), il bambino ha infatti la possibilità di confrontarsi quotidianamente con i propri punti di forza e con le proprie difficoltà e da tale esperienza può trarre insegnamenti validi per la vita. Ricordo ad esempio la gran difficoltà che trovavo nell’analizzare gli esperimenti di fisica o di chimica per desumerne le leggi e al contrario la facilità e la naturalezza con cui riuscivo ad affrontare le materie umanistiche, al punto che a distanza di dieci anni o più ricordo ancora a memoria i proemi di Iliade e Saga norrena imparate a scuola (in lingua originale!). Bene, questi diversi modi di reagire alle materie studiate hanno poi operato in perfetta unione nel corso dei miei studi superiori e musicali: la facilità in ambito umanistico e musicale infatti non avrebbe mai potuto evolversi se ad essa non si fosse aggiunta la consapevolezza della necessità di interrogarsi su ciò che sta dietro alle prime apparenze, pratica che era centrale nelle materie scientifiche affrontate a scuola.
La valorizzazione delle capacità dell’individuo però non sarebbe possibile se il bambino dovesse esclusivamente compierla da sé: di qui la centrale importanza che presso la nostra scuola assume il rapporto tra alunno e maestro, vero e proprio faber che quotidianamente offre alle menti “materiali” e “grezze” dei bambini spunti ed insegnamenti attraverso i quali esse possano plasmarsi ed affinarsi secondo le particolarità di ciascuno, edificando in tal modo con ogni alunno un rapporto irripetibile ed estremamente personale, incancellabile.
Tuttavia tale centralità del valore individuale risulterebbe sterile se fosse priva di una dimensione comunitaria. Questa dicotomia tra singolo e gruppo è rappresentabile con numerosi episodi tratti dal percorso della mia classe: per esempio il fatto di aver potuto allestire ben quattro recite nel corso di otto anni creò un’inevitabile consapevolezza collettiva all’interno del gruppo, in quanto ciascuno di noi, con la propria diversità e con il ruolo del proprio personaggio (sempre azzeccato), fu in grado di dare un contributo insostituibile all’interno di un’opera corale quale l’allestimento di uno spettacolo; proprio questa forza collettiva in continuo divenire, data dalla pluralità di singoli (aventi ciascuno punti di forza e di debolezza), diede a me ed alla mia classe la possibilità di lavorare fianco a fianco nel corso di varie feste scolastiche (Bazar di Natale, Feste di Primavera), di scoprire assieme il lavoro della terra (presso varie aziende agricole e creando un orto a scuola), di elaborare esperienze collettive e di esporne le nostre conclusioni (nell’ambito dell’apprendimento quotidiano ed in occasione di importanti esperienze formative), di affrontare le tappe del percorso didattico, di sperimentare assieme varie forme d’arte (dalla musica al teatro, dalla scultura alla pittura) confrontandoci continuamente e traendo spunto l’uno dall’altro per esprimere noi stessi accrescendoci.
Arrivando alla conclusione mi torna in mente uno dei più bei ricordi che io abbia della mia classe: l’immagine di una parete alla quale, in vista degli esami di ottava, ciascuno di noi aveva attaccato il proprio miglior disegno. Tali disegni, bellissimi singolarmente, assieme diventavano una vera e propria opera corale, un simbolo della crescita dell’uomo, fatta da ragazzi che nel corso degli anni si erano resi consapevoli del loro valore individuale ed irripetibile, imparando a rapportarsi con la necessaria dimensione comunitaria dell’essere umano, divenendo così splendidi tasselli del prodigioso mosaico dell’umanità.
T.B.